![FotoCopertina FotoCopertina]() di Anita Eusebi
di Anita Eusebi
“Impazzire si può”… Sì, certo che si può. Si può diventar matti, folli, avvelenati, schizofrenici, psicotici, depressi – e via diagnosi a non finire – quando la vita ti taglia il respiro di dolore, ingiustizie e miseria. E si può diventar matti anche senza che accada nulla di tutto questo. È spesso sufficiente che uno, un altro e un altro ancora ti puntino il dito addosso e ti dicano “matto”, in nome della loro “normalità” e del tuo essere “diverso”.
Per non parlare di chi continua a farne una questione genetica, e allora lì sei fritto, nasci col marchio e decidono per te che la tua vita sarà una merda. Lo dicono persino alcuni psichiatri, psicologi, scienziati, o peggio pseudogiornalisti che si nascondono dietro all’ultima news scientifica pescata a caso nel web e non perdono occasione di scrivere cazzate per poche decine di euro al pezzo, giocando come fosse niente con la sofferenza umana.
Le parole di Franco Basaglia di cui tutti ci facciamo bandiera e secondo le quali “la follia è una condizione umana” e ancora “in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione” tornano a oltre 40 anni di distanza a risuonare di una pesante attualità, di aspettative disattese, di muri che raccontano siano venuti giù, eppure sono ben in piedi davanti ai nostri occhi nell’indifferenza della maggior parte delle persone. Dicono che nel febbraio del ’73 un cavallo azzurro abbia buttato giù i cancelli dell’ex ospedale psichiatrico provinciale di San Giovanni di Trieste (oggi c’è chi lo chiama “parco culturale” perché fa figo e indubbiamente sposta l’attenzione dalle ombre tristi di quei luoghi ai colori sicuramente più chiari, ma non per questo talvolta meno ambigui, di una cultura fatta di libri e convegni…); dicono che quel pazzo di psichiatra filosofo di Basaglia abbia davvero reso possibile l’impossibile in quegli anni (restano un’eredità basagliana difficile da gestire e navi all’orizzonte da tenere bene d’occhio…); dicono che grazie alla legge 180 del ’78 “i manicomi non esistono più” e dicono anche che i “matti” (che oggi chiamano “utenti”, credendo di risolvere così quel che resta dello stigma e dei pregiudizi…) abbiano ormai pari dignità dei “normali” e piena cittadinanza nella Costituzione Italiana. Dicono.
All’edizione 2014 di “Impazzire si può” all’ex opp di Trieste lo scorso 25-26-27 settembre ci sono andata per guardarla in faccia, oggi, questa piena cittadinanza dei matti. E per sentirli parlare, i matti. Non gli psichiatri, i politici, i presidenti di, i direttori di, gli amici di amici di e via dicendo (insomma i soliti che se la suonano e se la cantano), ma coloro che vivono sulla propria pelle, quotidianamente, il disagio psichico e tutto ciò che questo comporta. I matti, appunto. Gli hanno ridato la parola, no? E allora, dopo aver letto tanto di filosofi, psichiatri, giuristi, letterati e cantautori, sono loro che voglio ascoltare, sono loro che voglio vedere seduti dietro i tavoli allestiti sul palcoscenico al centro della scena, sono loro che mi aspetto protagonisti di questo evento. Soprattutto, mi chiedo, “Impazzire si può” è uno slogan, un monito o una reale presa di coscienza che il dramma umano alla base del diventare matti è un qualcosa che può riguardare tutti indistintamente?
![Foto3 Foto3]()
Nei tre giorni dell’iniziativa triestina, di “persone con esperienza” (altro gioco di parole usuale, ma a mio avviso di poco senso…) ne ho incontrate tante. Ho riabbracciato persone care conosciute in questi anni, ho avuto il piacere di conoscere di persona altre anime belle sfiorate via social network, altre ancora sono state nuovi incontri capitati per caso con un «senti, ce l’hai una sigaretta?» o un «dai siediti qui, cazzo fai lì in piedi?», sospesi tra il mio sorriso di risposta, curioso e incerto, e un senso di familiarità piacevole e inaspettato. I matti… Li ho visti emozionarsi, ridere, commuoversi, ballare. Li ho visti seri, stanchi, con lo sguardo che ti scruta e poi se ne va per fatti suoi. Li ho visti seduti sui gradini del Teatro Basaglia a chiacchierare, sdraiati sui prati a godersi un po’ di sole, a Il Posto delle Fragole a prendersi un caffè. Ne ho visti pochi con un microfono in mano a raccontare e raccontarsi, sul palco. Alcuni, emozionatissimi, hanno letto e recitato storie di vita, di manicomi, di follia (scritte da psichiatri…). La maggior parte di loro è stata un insieme di comparse, hanno affollato il dietro le quinte, da attori non protagonisti, i loro volti e le loro voci hanno riempito tempi e luoghi non istituzionali, come quelli delle pause tra un intervento e l’altro da programma, o quello del dopocena quando il racconto sembra venire più scorrevole e si fa confidenza, gli sguardi, le lacrime e i sorrisi sono più sinceri, e i relatori in giacca e cravatta sono a cena altrove, e in altra compagnia.
Si fa presto a dire “matti”. «Posso offrirti un bianco?», mi dice Dario (Roma). Uno sguardo acuto e vivace, un sorriso simpatico e gentile. Mi racconta della sua vita, di un qualcosa che a un certo punto l’ha fermata e capovolta del tutto. Poche parole sul Santa Maria della Pietà, poi cambia discorso e torna a sorridere: «Ora sto bene, faccio teatro sai?». Ricordo gli occhi belli e lucidi di Paola (Modena) mentre mi racconta di aver partecipato, durante il viaggio di Marco Cavallo lo scorso novembre 2013, alla tappa presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Si commuove riportando le parole di un ragazzo internato nell’Opg e drammaticamente rassegnato, parole che valgono più di qualsiasi intervento ufficiale che ci rassicura con i “sì alla chiusura degli Opg, no alla costruzione delle rems” (ma la paura che il prossimo 1° aprile 2015 possa essere l’ennesimo, pessimo, pesce d’aprile targato Opg non ce la toglie nessuno…). Mi torna il sorriso pensando a Davide (Latiano), ai suoi occhi azzurri e luminosi, ai suoi appunti sul quaderno a righe (neanche a dirlo, più ordinati dei miei…), alle parole piene di gioia che mi ha regalato nel momento dei saluti.
![Foto2 Foto2]()
Camminando per San Giovanni sono tanti i pensieri che si affollano nella mente e con cui è difficile fare pace, viene voglia di sedersi sui gradoni della scalinata bianca e respirare intorno soltanto silenzio, nella penombra delle prime luci della sera. Dei tantissimi ex manicomi presenti in Italia, alcuni sono ruderi fatiscenti in uno stato di totale abbandono, altri sono stati riabilitati a giardini cittadini, sedi universitarie, musei, scuole superiori, uffici per la pubblica amministrazione, distretti sanitari. A San Giovanni, come altrove, i cancelli sono aperti, l’accesso è libero, l’ex opp è un via vai di autobus, automobili, motorini e pedoni. Chissà se qualcuno di loro, di tanto in tanto, ha mai un pensiero per altri visi, altri occhi, altri passi che soltanto pochi decenni fa abitavano questi luoghi. «Sono uno degli ultimi residui manicomiali di San Giovanni», mi dice Claudio Misculin, fondatore nel 1974 del gruppo teatrale Accademia della Follia, mentre attraversiamo a piedi i viali del parco, con un sorriso aperto, uno sguardo che non basterebbero parole e parole per raccontarlo e un filo sottile e tagliente di ironia.
All’uscita lo sguardo torna di sguincio sul cartellone enorme con la piantina ben dettagliata del parco. Lasciandomi alle spalle il cancello d’ingresso, ripenso allora che il parco è dedicato a un santo (Giovanni), il teatro a uno psichiatra (Basaglia), il bar a un film (Il Posto delle Fragole), la statua di ferro a un cavallo (Marco Cavallo), … Ma non c’è traccia in giro di quelli che furono i matti di San Giovanni, non un nome scritto su una targa apposta in un angolo in ricordo, una dedica, una poesia, insomma un omaggio del cavolo qualunque a tutte quelle vite abbandonate e perse in questi luoghi impregnati di un dolore così lacerante e profondo. Un’assenza pesante, qui come altrove. Peccato.
Sullo sfondo, in lontananza, il mare, il porto pieno di vele e un tramonto meraviglioso sembrano ammorbidire e sfumare per un attimo i contorni di una tristezza da turista sprovveduta e idealista. Al mare avrei voluto portarci la signora dai lineamenti scavati da una dentatura assente e da uno sguardo disperato che mi è piombata a un certo punto letteralmente addosso a San Giovanni mentre ero a prendere un caffè, mi ha stretto forte le mani e mi ha trascinata fuori ripetendo, come una bambina rimproverata che cerca protezione, «Andiamo via, portami al mare». Ho provato a sorriderle, a parlarle, a rassicurarla. Senza risultato. Come darle torto, d’altronde non ero che, probabilmente, l’ennesima stronza che non prendeva sul serio la sua richiesta. L’operatore che subito le è corso dietro a togliere le sue mani dalle mie glielo ha promesso, «Domani ti ci porto» le ha detto. Chissà se ce l’ha portata davvero. “Impazzire si può”, soprattutto se le brutture della vita ti costringono altrove mentre tu sogni di andare al mare.
[credits immagini Anita Eusebi]

 In poche righe una vita intera, spesa accanto alle persone che vivono la sofferenza del disagio mentale, lottando ogni giorno affinché non si smetta mai di restituire loro dignità, diritti e piena cittadinanza. Un impegno e una scelta di campo che si riflettono nelle porte aperte della presa in carico e della cura sul territorio. E ancora, in un’intensa attività di comunicazione sul tema della salute mentale. “La società stessa, attraverso una varietà di fattori, può concorrere a innescare la malattia mentale o può contribuire in maniera importante al suo aggravarsi o al suo risolversi. Ci vuole qualcosa di simile a una rivoluzione per mettere fine alla segregazione e allo stigma, per trasformare la cura psichiatrica da un sistema carcerario speciale in un sistema sanitario aperto, per dire no al pregiudizio” afferma il neuroscienziato portoghese Antonio R. Damasio, membro della Giuria del Premio Nonino, presieduta da V. S. Naipaul premio Nobel per la Letteratura 2001. “La giuria ha premiato Peppe Dell’Acqua per il suo fondamentale contributo a questa trasformazione, – prosegue Damasio – per aver richiamato l’attenzione sulla tragedia dell’ingiustizia e sulla necessità di cambiamento. Ha avuto un ruolo chiave in una rivoluzione che è ancora in atto. Il premio è per il lavoro di una vita.” Ed è un premio strameritato, perché la libertà è terapeutica, perché guarire si può, e dunque è necessario continuare a “basagliare”.
In poche righe una vita intera, spesa accanto alle persone che vivono la sofferenza del disagio mentale, lottando ogni giorno affinché non si smetta mai di restituire loro dignità, diritti e piena cittadinanza. Un impegno e una scelta di campo che si riflettono nelle porte aperte della presa in carico e della cura sul territorio. E ancora, in un’intensa attività di comunicazione sul tema della salute mentale. “La società stessa, attraverso una varietà di fattori, può concorrere a innescare la malattia mentale o può contribuire in maniera importante al suo aggravarsi o al suo risolversi. Ci vuole qualcosa di simile a una rivoluzione per mettere fine alla segregazione e allo stigma, per trasformare la cura psichiatrica da un sistema carcerario speciale in un sistema sanitario aperto, per dire no al pregiudizio” afferma il neuroscienziato portoghese Antonio R. Damasio, membro della Giuria del Premio Nonino, presieduta da V. S. Naipaul premio Nobel per la Letteratura 2001. “La giuria ha premiato Peppe Dell’Acqua per il suo fondamentale contributo a questa trasformazione, – prosegue Damasio – per aver richiamato l’attenzione sulla tragedia dell’ingiustizia e sulla necessità di cambiamento. Ha avuto un ruolo chiave in una rivoluzione che è ancora in atto. Il premio è per il lavoro di una vita.” Ed è un premio strameritato, perché la libertà è terapeutica, perché guarire si può, e dunque è necessario continuare a “basagliare”. di Alessandro Siciliano, socio-fondatore dell’Associazione Culturale Rizoma
di Alessandro Siciliano, socio-fondatore dell’Associazione Culturale Rizoma
 Si chiamava Giuseppe Casu. Faceva l’ambulante. Ed è morto dopo essere rimasto per sette giorni legato a un letto d’ospedale. I medici che lo hanno tenuto in queste condizioni sono stati assolti, anche in secondo grado. Ora però i giudici della corte d’appello di Cagliari hanno chiarito le motivazioni della sentenza. Di una assoluzione che, dicono, ha molti “ma”. Perché si tratta, scrivono i magistrati, di un «macroscopico caso di malasanità». Di una vicenda «dall’evoluzione incredibile» che deve essere conosciuta. Anche perché non è poi così “anormale” come sembra.
Si chiamava Giuseppe Casu. Faceva l’ambulante. Ed è morto dopo essere rimasto per sette giorni legato a un letto d’ospedale. I medici che lo hanno tenuto in queste condizioni sono stati assolti, anche in secondo grado. Ora però i giudici della corte d’appello di Cagliari hanno chiarito le motivazioni della sentenza. Di una assoluzione che, dicono, ha molti “ma”. Perché si tratta, scrivono i magistrati, di un «macroscopico caso di malasanità». Di una vicenda «dall’evoluzione incredibile» che deve essere conosciuta. Anche perché non è poi così “anormale” come sembra. di Anita Eusebi (pubblicato su
di Anita Eusebi (pubblicato su 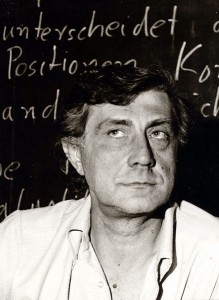
 da Piazza Grande, il giornale di strada
da Piazza Grande, il giornale di strada  di Anita Eusebi, da
di Anita Eusebi, da 

 di Anita Eusebi
di Anita Eusebi di Pier Aldo Rovatti
di Pier Aldo Rovatti




 di Anita Eusebi
di Anita Eusebi











